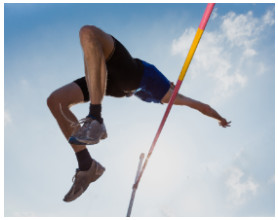di Luca Del Pozzo
In questi giorni che ci separano dal Sinodo dei giovani non ho potuto fare a meno di pensare che è oltremodo grottesco che proprio il beato Paolo VI, che sarà canonizzato il 14 ottobre nel bel mezzo del Sinodo, proprio lui rischia più di ogni altro di uscire con le ossa rotte, metaforicamente parlando s’intende, dai lavori sinodali. Le premesse, inutile girarci intorno, ci sono tutte. All’insegna dell’andazzo che oggi va per la maggiore, il gattopardismo alla rovescia: non cambiare nulla per cambiare tutto.
Il bersaglio grosso nella black list dei novatori, manco a dirlo, è l’Humanae Vitae. Ma siccome l’appetito vien mangiando, nel mirino sono finiti anche i rapporti pre-matrimoniali, l’aborto, la convivenza prima del matrimonio, e via smantellando. Compresa, tanto per non farsi mancare nulla, la famigerata gender theory. Leggere per credere il seguente passaggio dell’Instrumentun laboris del Sinodo:
“Ci sono giovani cattolici che trovano negli insegnamenti della Chiesa (sulle questioni di morale sessuale, ndr) una fonte di gioia e che desiderano che essa «non solo continui ad attenervisi nonostante la loro impopolarità, ma che li proclami insegnandoli con maggiore profondità» (RP 5). Quelli che invece non li condividono, esprimono comunque il desiderio di continuare a far parte della Chiesa e domandano una maggiore chiarezza a riguardo. Di conseguenza, la RP chiede ai responsabili ecclesiali di «affrontare in maniera concreta argomenti controversi come l’omosessualità e le tematiche del gender, su cui i giovani già discutono con libertà e senza tabù» (RP 11).
A parte il fatto che sfugge il senso della domanda di una “maggiore chiarezza” da parte di quei giovani che non condividono la morale sessuale della Chiesa (se non la condividono hai voglia a spiegare…), il resto è fin troppo chiaro: dalla riunione presinodale (abbreviazione RP nel testo, ndr) che si è tenuta dal 19 al 24 marzo 2018, è emersa la richiesta che i responsabili ecclesiali affrontino in maniera “concreta” – anche qui, cioè?? – argomenti controversi come l’omosessualità e le tematiche del gender – occhio adesso che arriva il bello – “su cui i giovani già discutono con libertà e senza tabù”. Oibò. E che vuol dire quel “senza tabù” riferito al gender? Forse che il gender è un problema solo per certi adulti magari un po’ bigotti e ottusi che vedono fantasmi e complotti ovunque, financo nelle fiabe innocenti, ma non per i giovani? E in che senso non sarebbe un problema? Nel senso che per un giovane d’oggi non è più scontata l’equazione tra identità di genere e dato biologico senza che questo rappresenti, appunto, un problema? O non piuttosto questo è il messaggio che si vuole far passare, spinto da quegli ambienti, esterni ma anche interni alla Chiesa che lavorano per sdoganare anche la teoria del gender tanto quanto l’omosessualità? (e non fa una piega, essendo il gender una variante dell’omosessualismo 3.0).
In realtà, è tutta l’impalcatura dell’Instrumentum Laboris a mostrare più di una crepa, non solo per gli aspetti citati. Tanto che Charles Chaput, arcivescovo di Filadelfia, ha sentito il dovere di mettere in guardia i fedeli (e non solo) circa i limiti dell’Instrumentum Laboris pubblicando sulla prestigiosa rivista amercana First Things (e ripreso in Italia sul sito de Il Timone), un articolo ricevuto da un rispettato teologo nordamericano. Articolo che mette a fuoco, appunto, i limiti o meglio le “difficoltà teologiche” del lavoro preparatorio del Sinodo, soffermandosi in particolare su cinque punti critici.
Il primo riguarda la prospettiva naturalistica che pervade l’impianto dell’Instrumentum. Prospettiva che, in estrema sintesi, si traduce nel mettere l’accento in modo eccessivo sulla dimensione per così dire orizzontale delle varie problematiche toccate, tralasciando del tutto o quasi quella che dovrebbe essere invece la dimensione privilegiata, ossia quella verticale. Si ha insomma l’impressione, a detta del teologo a cui si rifà Chaput, che la Chiesa sia più interessata a creare “cittadini responsabili” anzichè santi.
Altro punto critico, il modo in cui il documento pre-sinodale vede il ruolo della Chiesa, sostanzialmente un ruolo di semplice “ascolto” svilendone in tal modo l’autorità come se essa non possedesse la verità ma fosse solo una voce tra le altre nel dibattito pubblico. Col risultato che insegnanti e predicatori dovrebbero mettere da parte l’autorità per sostituirla, indovinate un po’, con il dialogo. Il che, sottolinea l’autore, pone un problema non solo teologico ma anche pastorale nella misura in cui i giovani hanno sì bisogno di qualcuno con cui parlare e che li sappia ascoltare, ma anche (e soprattutto) di guide, il che implica e richiede confrontarsi con l’autorità. In famiglia, in primis, ma anche altrove. Aperta parentesi.
Ci sarebbe molto da dire su questo aspetto, che tocca da vicino uno dei cavalli di battaglia della rivolta sessantottina, a causa della quale con l’acqua sporca è stato buttato anche il bambino. Checchè se ne dica, il frutto forse più marcio del sessantotto è stato proprio il rifiuto del principio di autorità, che ha minato fin dalle fondamenta i due capisaldi della società, la famiglia, appunto, e la scuola (oltre alle istituzioni e alla stessa Chiesa). Rivolta su cui, è bene ricordarlo a scanso di equivoci e per amor di verità (che viene prima di tutto il resto), non poca responsabilità ebbero anche certe esperienze sedicenti cattoliche, ad esempio in campo educativo. Prima fra tutte quella di Don Lorenzo Milani. L’ho già scritto altrove e lo riscrivo qui: con buona pace del priore di Barbiana, l’obbedienza è ancora una virtù. Ed è anzi l’unico, vero antidoto alla dittatura dell’Io e delle sue voglie, per dirla con Benedetto XVI. Non solo. Anche da un punto di vista squisitamente didattico, è tutto da dimostrare che la scuola di Barbiana sia stata un esperimento educativo di successo. Perché se è vero che la scuola di Don Milani non era per niente facile o poco esigente (grosso modo l’esatto opposto della scuola pubblica statale egemonizzata dalla sinistra che ha progressivamente spinto verso il basso l’asticella della formazione), è altrettanto vero che al pari dell’impostazione pedagogica della sinistra, la scuola di Don Milani era inficiata da una visione egualitaria – qui intesa come un “diritto” di tutti all’istruzione – che oltre ad essere, se possibile, più borghese che cristiana (e non sembri una contraddizione: è una costante della storia che le rivoluzioni siano sorte dall’alto e non dal basso), ha rappresentato di fatto un colpo micidiale alla meritocrazia.
Colpo micidiale, sia detto sempre ad onor del vero, per altro in aperto contrasto con lo spirito della Costituzione più bella del mondo la quale, spesso lo si dimentica, all’art. 34 recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Più chiaro di così si muore: hanno diritto di andare avanti negli studi i capaci e i meritevoli, non tutti. Nell’ovvio presupposto (ovvio per chi, come i padri costituenti, abbia una visione delle cose improntata al principio di realtà) che nella scuola, come in tutti gli ambiti della vita, esistono gli incapaci (che non è un insulto bensì la semplice presa d’atto di una non-capacità di fare delle cose. Io ad esempio non so dipingere né cucinare né ballare né tanto altro) e chi non merita di andare avanti. Tra l’altro, si potrebbe far notare en passant che anche in questo caso è scattata implacabile, come per tutto ciò che è ideologico, la dura legge dell’eterogenesi dei fini di vichiana memoria. Perché questa visione della scuola ha finito per innescare una dinamica sociale fortemente penalizzante e discriminatoria tale per cui se non sei diplomato/laureato non vali un fico secco. Il che è oltremodo paradossale, se si pensa che la spinta verso un allargamento della sfera dei diritti è venuta, appunto, da quella sinistra che da sempre ha fatto della difesa dei più deboli il suo cavallo di battaglia. E a proposito del dialogo, mai come ora tutti coloro che a vario titolo (stra)parlano del dialogo ogni due per tre come se esso fosse il fine e non un mezzo, farebbero bene a rileggersi l’enciclica Ecclesiam suam del beato Paolo VI (sì, ancora lui), laddove papa Montini con con quella raffinatezza intellettuale che lo contraddistingueva parla del dialogo come dello “sforzo di avvicinare il mondo, nel quale la Provvidenza Ci ha destinati a vivere, con ogni riverenza, con ogni premura, con ogni amore, per comprenderlo, per offrirgli i doni di verità e di grazia di cui Cristo Ci ha resi depositari, per comunicargli la nostra meravigliosa sorte di Redenzione e di speranza.” Altro che mutuo scambio di vedute, altro che semplice dibattito dove puntualmente ognuno resta della sua opinione; Paolo VI, nel solco della migliore tradizione ecclesiale, intendeva il dialogo come via, mezzo, strumento di evangelizzazione, nella piena consapevolezza che la Chiesa, ieri come oggi come domani, è depositaria non, appunto, di un’opinione ma della Verità. Un concetto riaffermato in quel libro di intatta bellezza intitolato (forse non a caso) “Dialoghi con Paolo VI”, dello studioso e amico Jean Guitton, dove a un certo punto Paolo VI dice: “Questo comune amore della verità è l’unica ragion d’essere del dialogo serio di cui parlo, che è molto diverso dai dialoghi mondani, dove si cerca solo di sembrare spiritosi, o, se si è furbi, di far credere che altri lo sono, come dice (credo), La Bruyeère.” Si applichi ora questo approccio al rapporto tra genitori e figli, e si vedrà chiara la distanza siderale tra il dialogare con i figli come lo intende il mondo e il dialogare alla luce della fede. Chiusa parentesi.
Terzo aspetto problematico dell’Instrumentum Laboris, una visione riduttiva dell’uomo, un’antropologia monca, che vede l’uomo tutto intelletto e desiderio o ragione e affettività, dimenticando che l’uomo – secondo l’antropologia più genuina – è unione di intelletto e volontà, senza la quale ogni possibilità di vita morale è esclusa.
Quarto: la vocazione. Anche qui, lo studio evidenzia un limite grossolano nella misura in cui sembra proporre una concezione “relativistica” della vocazione, senza ribadire che al di là e a prescindere dalla chiamata particolare di ciascuno, solo in Dio l’uomo può essere felice.
Quinto, e ultimo: il documento pre-sinodale sembra essere viziato da un certo sentimentalismo che cancella di fatto la Croce dalla vita dei giovani. Come se, appunto, solo una vita senza sofferenza può rendere l’uomo felice (il che rispecchia la posizione alquanto morbida di certi circoli ecclesiali nei confronti, ad esempio, dell’eutanasia).
Questi, in sintesi, i punti più problematici dell’Instrumentum Laboris, evidenziati dall’articolo da cui siamo partiti. Ma non gli unici, che anzi c’è molto altro di cui preoccuparsi, a partire dalla falsa dicotomia tra verità e libertà. Siamo insomma ben lontani dal modo in cui S. Giovanni parlava ai giovani nella sua prima lettera. E c’è solo da sperare che, come già accaduto in occasione del sinodo sulla famiglia, non ci si avventuri in improbabili riletture della dottrina cattolica che anziché rilanciare la sfida della fede aiutando i giovani ad innalzarsi alla statura del Vangelo, si risolvessero in un abbassamento dell’asticella alla statura della loro fede. Sarebbe il modo migliore per perderli. I giovani di minestrine annacquate non sanno cosa farsene. Chi ha orecchie per intendere, intenda.